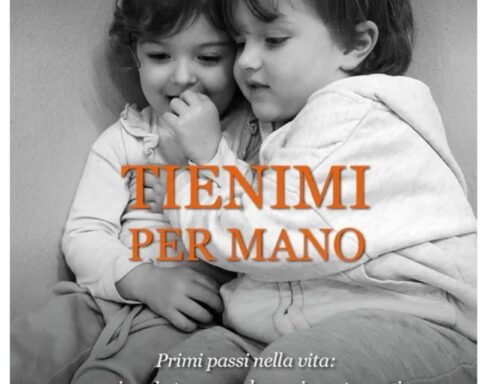Indice dei contenuti
Il 25 novembre è la giornata internazionale dedicata alla commemorazione e alla denuncia, ma la lotta contro il femminicidio esige un impegno che va oltre la singola data. Questa violenza estrema non è un’aberrazione momentanea, ma l’epilogo di un sistema di dominio e controllo alimentato da una profonda mancanza etica.
Come ci ricorda Hannah Arendt, il male si insinua spesso nella sua forma più inquietante: “Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale… era semplicemente senza idee.”
Questa “mancanza di idee” (l’incapacità di pensare empaticamente e giudicare moralmente) è il cuore psicologico dell’aggressore, il cui dramma si fonda sul narcisismo, ovvero l’amore patologico per un’immagine idealizzata di sé, a discapito della realtà e degli altri. L’aggressore traduce la propria fragilità e il desiderio di possesso in una violenza finale. Se il femminicidio è la “banalità del male” nella sua manifestazione più tragica, la nostra unica difesa è trasformare la denuncia annuale in un’azione quotidiana. L’obiettivo non è solo ricordare, ma rompere il ciclo della violenza prima che la mancanza di pensiero si trasformi in una perdita irreparabile.
Etimologia e storia del concetto di narcisismo
Il termine “narcisismo” affonda le sue radici nella mitologia greca, con il racconto di Narciso. Narciso era figlio del dio fluviale Cefiso e della ninfa Liriope. Alla sua nascita, il celebre indovino Tiresia profetizzò che il bambino avrebbe avuto una lunga vita, “a patto che non conoscesse mai se stesso” (ovvero, a patto che non vedesse mai il suo riflesso). Crescendo, Narciso divenne un giovane di straordinaria bellezza, ma era anche superbo e insensibile all’amore, respingendo ogni pretendente.
Tra le ninfe innamorate di lui c’era Eco. La ninfa era stata precedentemente punita dalla dea Giunone (moglie di Giove) e condannata a non poter più parlare per prima, ma solo a ripetere l’ultima parola di ciò che le veniva detto.
Eco si innamorò perdutamente di Narciso, ma la sua maledizione le impediva di esprimere il suo amore. Quando tentò di raggiungerlo, Narciso la respinse brutalmente, urlandole di allontanarsi.
Consumata dal dolore e dalla vergogna per il rifiuto, Eco si ritirò nelle caverne e sulle montagne fino a che di lei non rimase altro che la sua voce, che da allora ripete le parole degli altri.
Le altre ninfe e i giovani da lui disprezzati pregarono gli dei affinché Narciso provasse il dolore di un amore irrealizzabile.
La dea della vendetta, Nemesi, ascoltò le loro preghiere e decise di punire la sua vanità e il suo egoismo. Un giorno, mentre Narciso era assetato, si chinò su una fonte cristallina per bere. Non appena vide la sua immagine riflessa nell’acqua, si innamorò follemente di essa, credendo che fosse una splendida creatura. Comprese rapidamente che l’oggetto del suo amore, era il suo stesso riflesso e si rese conto dell’orrore della sua condizione: era condannato ad amare se stesso senza mai potersi congiungere con quell’immagine.
Narciso si consumò lentamente sulla riva della fonte, incapace di allontanarsi dal suo riflesso, smettendo di mangiare e bere.
Quando le ninfe vennero a raccogliere il suo corpo per il rito funebre, trovarono al suo posto un fiore, che da lui prese il nome: il Narciso (il fiore dal calice bianco e giallo, simbolo di vanità e morte).
Si narra che anche dopo aver attraversato lo Stige (il fiume dei morti), Narciso continuasse a contemplare il proprio riflesso nelle acque limacciose dell’Oltretomba.
La storia di Narciso è la metafora perfetta dell’egocentrismo patologico e dell’incapacità di amare l’altro, il che ha fornito la base per il concetto psicologico di narcisismo.

Il narcisismo nella Teoria Psicoanalitica di Freud
Freud affrontò il tema del narcisismo in diversi saggi, ma il più centrale è “Introduzione al narcisismo” del 1914.
1. Il narcisismo primario (la fase normale)
Freud postulò che il narcisismo non fosse inizialmente una perversione, ma una fase evolutiva normale e universale in tutti gli esseri umani:
Cos’è: È uno stato in cui il bambino (o il neonato) investe tutta la sua libido (energia psichica) sul proprio Io (Sé). Il bambino non ha ancora distinto il Sé dal mondo esterno e si sente l’unica, onnipotente realtà.
Funzione: Questo investimento libidico è cruciale per la formazione e l’unificazione dell’Io. È uno stato di “amore per sé” necessario per la sopravvivenza psichica.
2. Il narcisismo secondario (la patologia)
Il problema sorge quando questa libido, che dovrebbe gradualmente essere investita sugli oggetti esterni (i genitori, il mondo), viene ritirata da tali oggetti e reinvestita sull’Io.
Cos’è: È il ritorno, in età adulta, alla posizione del narcisismo primario.
Meccanismo: Avviene spesso in risposta a delusioni, traumi o fallimenti nelle relazioni esterne. L’individuo, non potendo più amare gli altri o essere amato da loro, si ritira e concentra l’amore su se stesso.
Conseguenze: Questo ritiro crea una patologia. L’individuo che si ritira nel narcisismo secondario non è più in grado di stabilire relazioni oggettuali sane e significative, perché la sua energia psichica è interamente auto-diretta. Questo è il fondamento che porta ai problemi di relazione che si vedono nel Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP).
3. La scelta oggettuale narcisistica
Freud distinse due modi principali in cui un individuo può scegliere un oggetto d’amore (partner, ecc.):
Scelta Oggettuale Anaclitica (o per Appoggio): L’individuo sceglie un partner basandosi sul modello di coloro che si sono presi cura di lui nell’infanzia (madre, padre).
Scelta Oggettuale Narcisistica: L’individuo sceglie un partner che:
È come lui: Una proiezione del proprio Io ideale.
È ciò che era: Qualcuno che rappresenta il Sé che ha lasciato.
È ciò che vorrebbe essere: L’Ideale dell’Io.
È stato una parte di sé: Qualcuno che serve a completarlo.
In sintesi, il contributo di Freud è stato cruciale perché ha trasformato il narcisismo da una semplice vanità in un concetto strutturale per comprendere la distribuzione dell’energia psichica e le fondamenta delle relazioni umane, sia nello sviluppo normale che nella psicopatologia.
L’uomo narcisista e manipolatore: atteggiamenti e frasi
L’uomo affetto da Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP), spesso con derive manipolatorie che lo avvicinano al Narcisismo Maligno (Kernberg), si manifesta attraverso un pattern pervasivo di grandiosità, bisogno di ammirazione e totale mancanza di empatia.
Gli atteggiamenti tipici seguono un ciclo:
Love Bombing: La fase iniziale di seduzione e idealizzazione. Frasi tipiche: “Sei l’unica persona che mi capisce davvero”, “Con te è diverso, non mi sono mai sentito così prima.”
Svalutazione e Gaslighting: Inizia la fase di abuso, in cui il partner viene sminuito e confuso. Il Gaslighting è l’arma principale, un abuso psicologico che porta la vittima a dubitare della propria percezione della realtà. Frasi comuni: “Stai esagerando”, “Sei troppo sensibile”, “Te lo stai inventando”, “Se l’ho fatto è perché mi hai costretto tu.”
Scarto: L’abbandono finale, spesso brutale e senza spiegazioni, quando la vittima non è più in grado di fornire il “rifornimento” (ammirazione, attenzione) di cui il narcisista ha bisogno.
Disturbo narcisistico di personalità (DNP) nel DSM-5
I criteri diagnostici per il Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP) sono definiti nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), che è il riferimento principale per la diagnosi in psicologia e psichiatria.
Secondo il DSM-5, il DNP è caratterizzato da un modello pervasivo di grandiosità (nella fantasia o nel comportamento), necessità di ammirazione e mancanza di empatia, che inizia entro la prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti.
Per una diagnosi, l’individuo deve mostrare cinque (o più) dei seguenti criteri:
Senso grandioso di sé (ad esempio, esagera risultati e talenti, si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza una giustificazione adeguata).
Preoccupazione per fantasie di successo illimitato, potere, splendore, bellezza o amore ideale.
Credere di essere “speciale” e unico e di poter essere capito solo da, o di doversi associare solo con, altre persone speciali o di status elevato.
Richiesta di ammirazione eccessiva.
Senso di diritto (cioè, irragionevoli aspettative di trattamenti di favore o di soddisfazione immediata delle proprie aspettative).
Sfruttamento interpersonale, cioè, approfitta degli altri per i propri scopi.
Mancanza di empatia: è riluttante a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri.
Invidia degli altri o la convinzione che gli altri siano invidiosi di lui/lei.
Comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
L’importanza della teoria dell’attaccamento di Bowlby
Il narcisismo patologico è spesso associato a uno stile di attaccamento insicuro, tipicamente Evitante o Distanziante (teoria di John Bowlby). La Base Sicura – la fiducia nella disponibilità della figura di attaccamento – viene a mancare nello sviluppo precoce del narcisista.
Il narcisista sviluppa una strategia difensiva di negazione del bisogno di attaccamento, sostituendo la vera intimità con una facciata di superiorità e autosufficienza. La grandiosità è un meccanismo di difesa contro un profondo senso di fragilità.
La Teoria dell’Attaccamento, sviluppata dallo psichiatra britannico John Bowlby, è un fondamentale approccio psicologico che spiega come i legami emotivi precoci formati con i caregiver influenzino la nostra vita relazionale e il nostro benessere emotivo.
Bowlby sostenne che l’attaccamento non è un meccanismo appreso basato sul bisogno di cibo (come ritenevano alcune teorie dell’epoca), ma un sistema motivazionale primario con radici evoluzionistiche. Il neonato è geneticamente predisposto a cercare la vicinanza fisica e la protezione della figura di accudimento, perché tale vicinanza aumenta le sue possibilità di sopravvivenza.
Il ruolo centrale del caregiver è quello di fornire una base sicura (secure base). Da questa posizione di sicurezza, il bambino si sente abbastanza protetto e tranquillo da potersi allontanare per esplorare il mondo circostante e imparare. La base sicura è il rifugio emotivo a cui il bambino può tornare per ricevere conforto e regolazione emotiva in momenti di paura o stress.
Le interazioni ripetute tra il bambino e il caregiver plasmano delle rappresentazioni mentali profonde chiamate Modelli Operativi Interni (MOI). Questi MOI sono delle vere e proprie mappe cognitive e affettive che l’individuo utilizza per interpretare, prevedere e costruire tutte le sue relazioni intime future. I MOI rispondono essenzialmente a due domande chiave: “Sono amabile e degno di aiuto?” (Modello del Sé) e “Le persone sono affidabili e disponibili?” (Modello degli Altri).
La qualità dell’accudimento – in particolare la sensibilità e la disponibilità del caregiver – determina lo stile di attaccamento. Quando il caregiver è coerentemente sensibile e disponibile, si sviluppa l’attaccamento sicuro, che porta l’adulto a essere fiducioso, equilibrato e a proprio agio con l’intimità. Al contrario, figure di accudimento incoerenti, rifiutanti o spaventanti portano allo sviluppo di stili insicuri (come evitante, ansioso o disorganizzato), che si manifestano in età adulta con difficoltà nella regolazione emotiva, paura dell’abbandono o evitamento.
In sintesi, la teoria di Bowlby sostiene che l’esperienza relazionale primaria è il progetto fondamentale che modella la nostra personalità e la nostra capacità di affrontare le sfide della vita e delle relazioni.
Il narcisismo psicoanalitico: scontro tra patologia strutturale e arresto evolutivo
Nel panorama della psicoanalisi moderna, la comprensione del narcisismo patologico è stata profondamente plasmata e dibattuta dalle visioni divergenti di due giganti: Otto Kernberg e Heinz Kohut. Le loro teorie offrono prospettive contrastanti non solo sulla natura del disturbo, ma anche sull’approccio terapeutico più efficace.
Kernberg definisce il narcisismo come una patologia strutturale e severa, radicata in un fondamentale fallimento nell’integrazione dell’Io. Secondo la sua teoria delle relazioni oggettuali, l’individuo narcisista patologico non è riuscito a integrare gli aspetti “tutto buono” e “tutto cattivo” di sé e degli altri, utilizzando la difesa primitiva della scissione (splitting). Questo porta alla formazione di un Sé grandioso patologico, che è una fusione difensiva tra il Sé ideale, l’oggetto ideale e il Sé reale. La sua visione è più cupa e mette in luce l’aggressività, l’invidia e la tendenza alla svalutazione degli altri come meccanismi centrali. Kernberg ha anche introdotto il concetto di Narcisismo Maligno, una forma particolarmente grave che combina le caratteristiche narcisistiche con forti tendenze antisociali, aggressività e paranoia, ritenendolo al confine con la psicopatia.
Kohut, d’altro canto, con la sua Psicologia del Sé, offre una visione più empatica e orientata allo sviluppo. Egli interpreta il narcisismo non come una difesa aggressiva, ma come il risultato di un arresto evolutivo. Secondo Kohut, il bambino ha bisogni legittimi del Sé (self-objects) – come i bisogni di specularità (essere rispecchiato e ammirato) e di idealizzazione(poter ammirare figure genitoriali forti) – che sono stati cronicamente insoddisfatti da caregiver fallaci nell’empatia. L’individuo adulto narcisista cerca disperatamente di compensare questi vuoti relazionali precoci. Kohut riteneva che l’approccio terapeutico dovesse essere focalizzato sull’empatia e sull’accettazione, permettendo al paziente di riattivare questi bisogni (attraverso il transfert narcisistico) per riparare lo sviluppo interrotto.
In sostanza, dove Kernberg vede un Sé arrogante e distruttivo da confrontare, Kohut vede un Sé vulnerabile e ferito da accogliere e rispecchiare, delineando due approcci radicalmente diversi al trattamento del disturbo narcisistico di personalità.
Il narcisismo, la violenza e i casi di femminicidio in Italia
Il narcisismo patologico, soprattutto nelle sue forme più maligne e antisociali, è un fattore di rischio cruciale nei femminicidi, essendo mosso dalla necessità di controllo totale e dall’incapacità di accettare il rifiuto.
Percentuali e Contesto Globale
A livello globale, le statistiche dell’ONU indicano che una percentuale elevata (stimata attorno al 50-60%) dei femminicidi viene commessa dal partner o ex-partner della vittima. Sebbene non tutti questi autori siano clinicamente diagnosticati come narcisisti, la dinamica scatenante è quasi sempre riconducibile alla possessività, gelosia patologica e annullamento della volontà altrui, tratti distintivi del narcisismo.
Panoramica dei casi italiani
I casi che hanno sconvolto l’Italia mostrano chiaramente il pattern del dominio:
Giulia Cecchettin (2023): Uccisa dall’ex fidanzato. È diventato simbolo del patriarcato criminale e dell’incapacità di accettare l’autonomia della donna.
Giulia Tramontano (2023): Uccisa dal compagno mentre era incinta. Un caso emblematico di freddezza e pianificazione, mosso dalla reazione violenta al fallimento del suo piano di controllo.
Saman Abbas (2021): Uccisa dalla famiglia a causa del rifiuto di un matrimonio combinato, riflettendo una logica di dominio totalitario sulla volontà femminile.
I criminologi Roberta Bruzzone e Massimo Picozzi hanno analizzato queste dinamiche, evidenziando come la violenza fisica sia spesso l’epilogo di una distruzione emotiva e psicologica pregressa. La Bruzzone ha parlato di “Patriarcato Criminale”, mentre Picozzi in Verbal Warrior si concentra sulla violenza verbale e psicologica come fase cruciale del controllo.
La giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999. Questa data è un momento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sulla natura sistemica della violenza di genere. Serve a denunciare tutte le forme di abuso—dalla violenza fisica al controllo psicologico ed economico (forme spesso agite dal narcisista manipolatore)—e a promuovere azioni concrete per la prevenzione, la protezione delle vittime e l’educazione al rispetto. È un richiamo globale alla necessità di smantellare le radici culturali del patriarcato.
La donna vittima: profilo e difesa
La donna che sottostà al narcisista è spesso una persona con un’alta dose di empatia, una profonda paura dell’abbandono o un basso senso di autostima. Questa vulnerabilità la rende bersaglio ideale del Love Bombing e della manipolazione.
Le Armi di Difesa e L’Atteggiamento
“No Contact” e Confini Rigidi: L’arma più efficace è l’isolamento emotivo e fisico totale (No Contact), negando al narcisista il “rifornimento”.
Riconoscimento e Ristrutturazione Cognitiva: La vittima deve riconoscere che il problema risiede nella patologia del partner e non in una sua presunta inadeguazione, uscendo dal Gaslighting.
Lavorare sulla Base Sicura: A livello terapeutico, la vittima deve ricostruire la propria Base Sicura interna e imparare a validare le proprie emozioni senza dipendere dall’approvazione esterna.
La via d’uscita: autonomia, autostima e difesa del sé
La vera prevenzione contro la violenza relazionale passa attraverso l’empowerment della donna su tre livelli fondamentali:
Autonomia Economica: Essere economicamente autosufficiente è il pilastro della libertà. La dipendenza finanziaria è uno degli strumenti di controllo più subdoli e potenti utilizzati dal narcisista. Un lavoro stabile o un piano di indipendenza consentono alla donna di attuare la “scissione” e di abbandonare la relazione senza temere la rovina materiale.
Potenziamento dell’Autostima: L’autostima non è un regalo, ma il risultato di un lavoro attivo: volersi bene significa stabilire confini, non tollerare il Gaslighting e non cercare la propria validazione nella grandiosità tossica del partner. Coltivare passioni e fare ciò che rende felici serve a costruire un senso di valore interno, impermeabile alle svalutazioni esterne.
Difesa Fisica e Consapevolezza: L’integrazione di nozioni di difesa personale sin dall’asilo o dalla scuola può infondere non solo tecniche fisiche, ma soprattutto la consapevolezza di avere il diritto di difendersi e di occupare il proprio spazio, trasformando il corpo da potenziale vittima a strumento di autodeterminazione.
Tutela legale e supporto sociale
La Legge e Le Associazioni
In Italia, la protezione delle vittime di abusi psicologici e stalking è garantita principalmente da:
Codice Rosso (Legge 69/2019): Ha introdotto procedure più rapide e pene più severe per atti persecutori (stalking, Art. 612-bis c.p.) e maltrattamenti in famiglia (Art. 572 c.p.).
Misure Cautelari: Ammonimento del Questore e Divieto di avvicinamento sono strumenti legali fondamentali.
Le Associazioni come Telefono Rosa offrono ascolto h24, supporto psicologico e assistenza legale gratuita, fungendo da cruciali basi sicure esterne per le vittime.
L’Aggiornamento Essenziale: Consenso Libero e Attuale
L’aggiornamento legislativo cruciale (approvato in Commissione Giustizia nel novembre 2025) è la modifica dell’Articolo 609-bis del Codice Penale.
L’impatto è: il reato di violenza sessuale si configura ora con la sola assenza del consenso.
Principio Base: Si adotta il “Solo SÌ è SÌ“.
Novità: Non è più necessario dimostrare l’uso di violenza o minaccia. Basta la mancanza di un consenso chiaro, dato liberamente e valido al momento dell’atto, per far scattare il reato.
Il Focus passa dalla resistenza della vittima, al dovere di assicurarsi il consenso, da parte di chi compie l’atto.
Riflessioni personali: le radici del controllo e del possesso
Dal punto di vista psicologico, il femminicidio non è un “delitto passionale”, ma l’atto estremo di un sistema di controllo e dominio.
1. La Fragilità narcisistica dell’aggressore
Molti atti di violenza, che culminano nel femminicidio, sono guidati da una profonda fragilità narcisistica dell’aggressore. L’uomo vede la donna (la partner o ex) non come un individuo autonomo, ma come un’estensione di sé o una proprietà. Quando la donna esercita la sua autonomia (lasciandolo, denunciandolo, o semplicemente vivendo la sua vita), questa azione viene percepita come un’umiliazione insopportabile e una minaccia esistenziale al suo senso di potere.
Riflessione: Il femminicidio è il tentativo disperato di ripristinare, attraverso la violenza finale, il controllo su un oggetto che osa sottrarsi.
2. La deumanizzazione e la banalizzazione
Per commettere un atto così estremo, è necessario un processo di deumanizzazione della vittima. L’aggressore, spesso supportato (anche inconsciamente) da stereotipi culturali sulla subordinazione femminile, spoglia la donna della sua dignità e dei suoi diritti, riducendola a un ostacolo, una colpa o un’entità da eliminare. Questo meccanismo psicologico permette di bypassare il naturale freno all’omicidio.
3. L’Escalation della Violenza
Il femminicidio non è quasi mai un evento isolato. È il punto finale di una spirale di violenza fisica, emotiva ed economica, spesso caratterizzata dal ciclo dell’abuso:
Fase di tensione crescente
Fase dell’incidente violento acuto
Fase della “luna di miele” o della riconciliazione (con promesse di cambiamento). La mancata rottura di questo ciclo alimenta la convinzione dell’aggressore di poter agire impunemente.
Prospettiva empatica: il fallimento umano
L’empatia è la capacità di comprendere e condividere i sentimenti degli altri. Il femminicidio è un atto di totale assenza e fallimento dell’empatia.
1. La negazione dell’altro
Quando l’empatia è negata, l’aggressore non percepisce il dolore, la paura o il diritto alla vita della vittima. L’altro non è più un essere umano con una soggettività, ma solo l’incarnazione della frustrazione, della rabbia o del rifiuto che l’aggressore sta provando.
Riflessione: La vera tragedia emotiva risiede nel fatto che l’amore o l’attaccamento (spesso distorto) si trasforma in un odio così radicale da annientare l’oggetto del sentimento, pur di non accettare la perdita o il rifiuto.
2. L’Impatto Collettivo del Trauma
Da una prospettiva empatica, il femminicidio non è solo la morte di una donna, ma una ferita che si propaga nella comunità. Provoca:
Trauma vicario: Colpisce amici, familiari e figli, i quali subiscono il trauma di aver perso una persona cara nella maniera più violenta e incomprensibile.
Paura sistemica: Genera un senso di insicurezza e vulnerabilità in tutte le donne, che vedono in ogni notizia la conferma che la loro libertà può costare la vita.
Dolore empatico: La società è chiamata a sentire il dolore di questa ingiustizia e a riconoscere il fallimento delle istituzioni e delle relazioni che non sono riuscite a proteggere la vittima.
La scelta quotidiana tra empatia e banalità del male
La Giornata del 25 Novembre ci impone di guardare la realtà del femminicidio non come un’emergenza isolata, ma come il tragico epilogo di una violenza sistemica, un fallimento relazionale e sociale che si consuma nel silenzio. La riflessione psicologica, che sia attraverso l’analisi freudiana del narcisismo, la patologia del controllo di Kernberg o la negazione dell’attaccamento, ci svela una verità scomoda: l’atto omicida è raramente un raptus, ma l’ultimo, brutale tentativo di un individuo di ripristinare un controllo perduto su un oggetto che gli era percepito come estensione del sé, alimentato da una profonda fragilità narcisistica.
Il dramma risiede proprio in ciò che Hannah Arendt chiamava la “mancanza di pensiero”. Il femminicida non è sempre il mostro demoniaco atteso, ma l’uomo che, nel momento del rifiuto o dell’abbandono, rinuncia alla sua capacità etica di mettersi nei panni dell’altro, negando totalmente l’empatia e la dignità della vittima. Questo è il punto in cui la responsabilità sociale e personale si fondono: il male diviene banale quando smettiamo di pensare e giudicare.
Per questo motivo, la lotta al femminicidio è, come recita il titolo, un impegno che deve essere quotidiano. Non possiamo limitarci a indossare nastri o a marciare una volta all’anno. Rompere il ciclo della violenza significa educare all’empatia fin dall’infanzia, insegnare la gestione non violenta della frustrazione e del rifiuto e decostruire attivamente la cultura del possesso e della supremazia. Significa intervenire in ogni segnale di abuso psicologico o controllo che precede l’irreparabile. Solo trasformando la nostra indignazione in una responsabilità civile costante, accettando che la prevenzione è un dovere che riguarda tutti, potremo onorare le vittime e sperare di smettere di contare i femminicidi come una tragica, ma evitabile, consuetudine. La sfida è quella di sostituire la “banalità del male” con la radicalità dell’amore e del rispetto per l’autonomia dell’altro.
“Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” — Virginia Woolf. (Una stanza tutta per sé)
Ho scelto questa frase finale poiché è ideale per sottolineare che il femminicidio è l’atto estremo per sopprimere la libertà e l’indipendenza della donna. L’atto omicida è il tentativo definitivo e brutale di regolare (controllare) la libertà e l’autonomia della donna, ma la citazione sancisce che il suo spirito e la sua mente restano, moralmente liberi, sempre. È un inno alla resistenza della dignità.