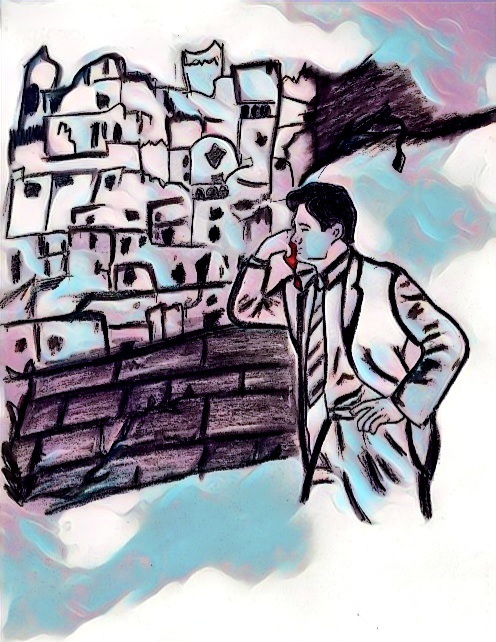Indice dei contenuti
L’orsa che mangiava ciliegie
(Mauro Balboni, in uscita a inizio 2026)
L’orsa che mangiava ciliegie. I castori che nuotano sotto i palazzi della city finanziaria. Il lupo in giardino. Le foreste ripariali a 20 km da piazza Duomo. Le scale dei fiumi dove passano i grandi storioni dopo 60 anni di assenza. La foresta lasciata evolvere secondo le sue leggi. I bisonti di Giulio Cesare e Asterix. I miracolosi boschi delle risorgive nella pianura più cementificata d’Europa. E molto altro.Cos’è: un bestiario da leggende metropolitane? No: sono incontri reali con la nuova natura europea. La wilderness diversamente selvaggia che sta prendendo forma nel primo continente che la wilderness la cancellò quasi dovunque. Eppure, sta ritornando. Qui e là, a brandelli, più spesso che no ferocemente avversati.
Un racconto di crisi e cambiamento
L’orsa che mangiava ciliegie di Mauro Balboni racconta inevitabilmente la crisi ecologica e climatica che stiamo vivendo, e non potrebbe essere diversamente.
Ma, per una volta, dalla parte di quello che sta provando ad adattarsi. Quello che ogni anno aggiunge un anello nel tronco anche se deformato da siccità e inquinanti ambientali. Quello che è tornato a scorrere dove non scorreva più. Quello che riappare su montagne da dove pensavamo di averlo scacciato per sempre. Quello che non ha voce ma deve essere fatto conoscere, per evitare che venga perso di nuovo.
Le domande che dobbiamo farci
Sono incontri che spalancano la porta direttamente sui grandi temi del nostro tempo: il clima, la difesa dagli eventi metereologici estremi, i servizi ecosistemici, la vivibilità dell’ambiente costruito, l’overtourism. Che ci parlano di amnesia ecologica generazionale, di rewilding, di quale ruolo per le aree protette. Di quale futuro ci aspetta.
L’orsa che mangiava ciliegie ci conduce ad affrontare domande per le quali non abbiamo ancora risposte, ma che forse aprono uno spiraglio di speranza: quell’orsa, quei castori, quelle nuove foreste, quegli storioni sono qui per rimanerci? Sono ecologicamente reversibili, i disastri dell’Epoca Umana?
Il rewilding e la coesistenza tra uomo e natura selvatica
Il concetto di “rewilding” non è più una visione romantica, ma un approccio pratico alla conservazione, basato sul lasciare spazio ai processi naturali e sul ritorno, spesso spontaneo, delle specie chiave. Il fenomeno narrato da Balboni si inserisce perfettamente in questo contesto europeo, dove i lupi tornano ad attraversare le Alpi e i castori rimodellano i corsi d’acqua a ridosso delle aree urbane. Questo ritorno della fauna selvatica pone però un’ardua sfida: la coesistenza. Se da un lato il ripristino della biodiversità porta benefici tangibili, come una maggiore resilienza agli eventi climatici estremi o la fornitura di servizi ecosistemici essenziali, dall’altro lato, richiede una profonda revisione del rapporto tra uomo e fauna selvatica. Il libro di Balboni, dunque, non celebra solo il trionfo della natura, ma indaga anche le complesse dinamiche sociali, economiche e culturali che si attivano quando la wilderness irrompe nella quotidianità antropizzata.
La resilienza naturale contro la crisi delle risorse
Questa prospettiva, ricca di incontri sorprendenti, offre un contrasto significativo con le preoccupazioni più drammatiche espresse dall’autore in merito alla sicurezza alimentare e alla gestione delle risorse, temi centrali nel suo precedente saggio, “Il pianeta dei frigoriferi” (2022). Dopo aver analizzato lucidamente le criticità strutturali e globali dell’impronta umana sulle risorse, l’autore in questa nuova opera rivolge lo sguardo ai segnali di resilienza che la natura, nonostante tutto, continua a offrire. L’orsa che mangiava ciliegie si presenta quindi come un invito a considerare i meccanismi di adattamento del mondo naturale non come un’alternativa alle soluzioni tecnologiche o politiche, ma come una parte essenziale e forse decisiva per immaginare un futuro sostenibile, dove uomo e natura possano trovare un nuovo equilibrio.
Mauro Balboni
Mauro Balboni è nato a Bolzano nel 1958 e vive oggi in Svizzera (dopo essere passato per Austria e Inghilterra). Si è laureato in Scienze Agrarie all’Università di Bologna. È stato dirigente di livello internazionale nell’agroindustria, per la quale ha lavorato sia nella ricerca & sviluppo che negli affari governativi. Ha lavorato oltre 30 anni nella ricerca e sviluppo della grande industria agrochimica, la maggior parte dei quali come dirigente con responsabilità europee e globali. Ha vissuto a Milano, Bologna, Vienna, Oxford, Zurigo. Oggi risiede tra la Svizzera e il lago di Garda, dove ha trovato la sua vera life mission, quella di conservare un biotopo di prati magri e i suoi legittimi residenti: le “carote ametista”, le cavallette dalle ali blu, le api, le farfalle e le orchidee rare. Dal 2017 scrive sui temi della sicurezza alimentare globale e dell’impronta del cibo sulle risorse e gli ecosistemi, prima con Il Pianeta mangiato e più recentemente con Il pianeta dei frigoriferi (edito da Scienza Express e uscito a maggio 2022). Nel resto del suo tempo gira l’Europa con il camper, a piedi o in bicicletta anche alla ricerca di agricolture e di cibi presenti, passati e futuri.