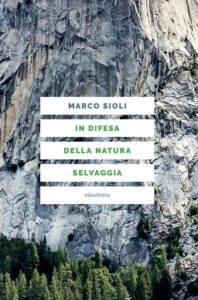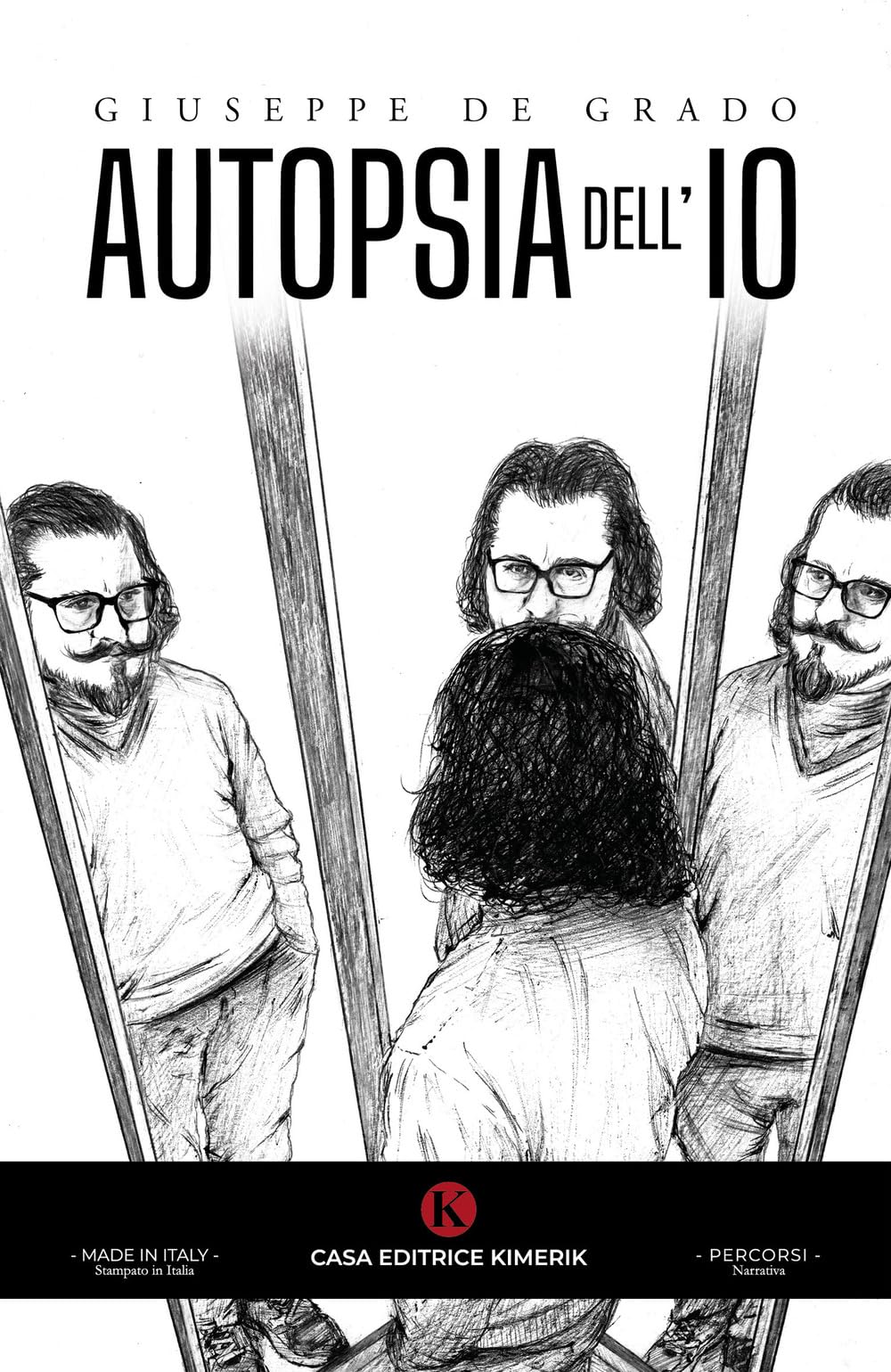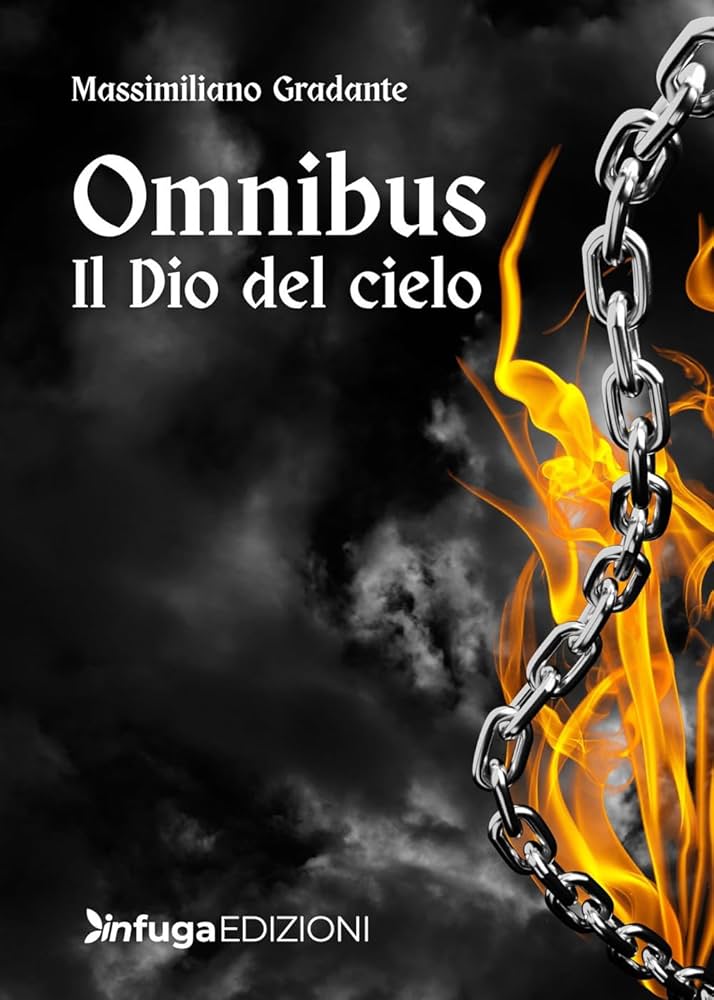Indice dei contenuti
In difesa della natura selvaggia di Marco Sioli è un saggio fondamentale e urgente, che traccia la storia del concetto di wilderness americana per riflettere sulla crisi ecologica contemporanea. Il libro analizza la nascita dell’ambientalismo attraverso figure chiave come John Muir, Aldo Leopold e Henry David Thoreau, mostrando il conflitto tra protezionismo biocentrico (la natura ha valore intrinseco) e antropocentrismo (la natura come risorsa).
L’evoluzione di un’idea selvaggia
L’etimologia del conflitto: dal deserto sacro alla minaccia
In difesa della natura selvaggia di Marco Sioli (Elèuthera) non è una semplice ricostruzione storica, ma un viaggio attraverso l’evoluzione della Wilderness: da spazio geografico a campo di battaglia culturale e politico. La tesi del libro è netta: la “natura selvaggia” non è una realtà fissa, ma un’idea in continuo mutamento, una costruzione culturale che ogni epoca ha interpretato secondo le proprie paure e le proprie visioni del mondo.
In origine, wilderness evocava il deserto sacro, un luogo ostile e caotico, spesso associato al male, all’ordine “selvaggio” da domare. L’antropocentrismo ne fece un territorio da conquistare, più che da comprendere. A dominare era la paura del non controllato.
Con il trascendentalismo questa percezione si ribalta. In Henry David Thoreau la wilderness diventa un santuario morale, la fonte di una verità più profonda. John Muir, padre del protezionismo americano, porta questa intuizione alle estreme conseguenze, affermando il valore intrinseco degli ecosistemi. Celebre la sua frase:
“Migliaia di persone stanche, nervose e troppo civilizzate stanno cominciando a scoprire che andare sui monti è tornare a casa… la natura selvaggia è una necessità.”
Oggi, nella crisi ecologica globale, la wilderness non è più percepita come minaccia, ma come ciò che rischia di scomparire sotto la pressione del capitalismo estrattivo. Sioli utilizza questa evoluzione semantica per mostrare come la wilderness sia un campo di tensione: tra chi la vede come comunità vivente e chi come deposito di risorse.
Le colonne dell’ambientalismo americano
Il saggio ruota attorno a quattro figure monumentali che hanno fondato l’ambientalismo statunitense, integrando filosofia, politica e paesaggio.
Henry David Thoreau è la radice filosofica. L’esperienza di Walden e la vita semplice diventano un esercizio morale: “in wildness is the preservation of the world”. La wilderness è soprattutto un luogo interiore.
Frederick Law Olmsted, celebre per Central Park, introduce la dimensione sociale: la natura come bene comune. Per lui, gli spazi verdi devono essere accessibili a tutti e svolgere una funzione democratica. Nel suo rapporto su Yosemite (1865) denuncia il rischio della privatizzazione e difende l’integrità degli ecosistemi come condizione per la salute collettiva.
John Muir, fondatore del Sierra Club, è la voce spirituale e radicale del protezionismo. Difende Yosemite e le aree selvagge non in nome dell’utilità, ma perché esistono. Un biocentrismo netto, che vede gli ecosistemi come comunità interdipendenti dotate di pari dignità.
Aldo Leopold, con A Sand County Almanac, porta questo pensiero a maturazione etica. La sua Land Ethic estende la nozione di comunità includendo suoli, acque, piante e animali. Non più uomo contro natura, ma uomo dentro la natura. È il ponte tra protezionismo e ecologia moderna.
Queste quattro visioni, pur diverse, costruiscono l’ossatura dell’ambientalismo contemporaneo.
Olmsted e il diritto al godimento popolare
Olmsted porta nella storia dell’ambientalismo un’idea rivoluzionaria: la natura come diritto sociale. Central Park non è un’opera estetica, ma un progetto politico. In una società industriale sempre più alienata, gli spazi verdi diventano luoghi di cura, uguaglianza, riequilibrio.
Nel suo rapporto su Yosemite, Olmsted non difende solo la bellezza del paesaggio, ma il suo ruolo ecologico: la tutela delle sorgenti, delle foreste, dei corsi d’acqua. Comprende che il paesaggio naturale è una struttura fragile e interdipendente. La sua visione anticipa l’idea della wilderness come bene comune: non un lusso, ma una forma di giustizia.
L’Orso e l’etica della coesistenza in Italia
La controversia italiana sugli orsi è la prova più immediata della distanza tra la visione biocentrica di Muir e Leopold e l’antropocentrismo politico attuale. Muir vedeva negli orsi creature da trattare con rispetto, “giardinieri” dei boschi; ricordava che l’uomo è spesso “il loro più grande nemico”.
Oggi, invece, la risposta istituzionale a incidenti con la fauna selvatica consiste spesso nell’abbattimento dell’animale, come se l’istinto naturale fosse un crimine. Si punisce la natura quando non si conforma alle regole umane. È il contrario della Land Ethic, che vede nell’interdipendenza il fondamento della convivenza.
Il problema non è la sicurezza, ma l’educazione ambientale. Senza consapevolezza dei diritti degli animali e dei limiti umani, la coesistenza è impossibile. Ci muoviamo nei boschi come se fossero parchi giochi, ignorando le responsabilità che comporta entrare nel territorio dell’altro. La politica, invece di educare, usa la paura come leva propagandistica.
La wilderness come specchio della crisi globale
Dalla foresta alla città: la wilderness interiore
Se i grandi parchi americani sono lontani o compromessi, la domanda è: dove si colloca oggi la wilderness? Sioli risponde seguendo Leopold: nella capacità di costruire una wilderness interiore e politica.
La Land Ethic diventa il ponte tra natura incontaminata e città. Significa estendere il concetto di comunità anche a suoli, acqua, animali urbani, micro-ecosistemi. Non proteggere per lasciare intatto, ma agire in armonia con ciò che resta.
La sfida è creare spazi di coesistenza: micro-riserve, corridoi ecologici, giardini “selvatici”, margini periurbani rinaturalizzati. Non potendo più andare nel bosco di Thoreau, dobbiamo portare il bosco nelle scelte quotidiane.
Dalle osservazioni di Olmsted alle alluvioni climatiche
La fragilità idrica di oggi ha radici antiche. Olmsted denunciava già nel XIX secolo come il disboscamento compromettesse le sorgenti e destabilizzasse i fiumi. Muir e Leopold parlavano dell’acqua come membro della comunità ecologica, non come semplice risorsa.
Oggi queste intuizioni risuonano nelle alluvioni italiane: consumo di suolo, cementificazione, canali artificiali, ignoranza delle dinamiche naturali. La crisi climatica amplifica problemi creati da decenni di gestione predatoria.
La difesa della wilderness, nel XXI secolo, è anche lotta per la rinaturalizzazione dei fiumi: restituire spazio all’acqua significa restituire equilibrio alle comunità che la abitano.
La Wilderness oggi in Italia: dove siamo davvero
1. Parchi nazionali sotto pressione
L’Italia ha zone di pregio straordinario (Gran Paradiso, Abruzzo-Lazio-Molise, Foreste Casentinesi), ma la pressione antropica è altissima: strade, seconde case, turismo intensivo, frammentazione degli habitat. La wilderness esiste, ma è spesso circondata o invasa.
2. Il caso degli orsi: la coesistenza mancata
Le tensioni sugli orsi trentini rivelano un problema culturale prima che gestionale: non conosciamo più gli animali che abitano i nostri territori. Educazione ecologica quasi assente, politica oscillante tra allarme e propaganda.
3. I fiumi canalizzati e la crisi idrica
Molti corsi d’acqua italiani sono stati rettificati, arginati o trasformati in canali. Questa perdita di naturalità aumenta il rischio di alluvioni e riduce la biodiversità. La “wilderness fluviale” è quasi scomparsa, ma progetti di rinaturazione (come sul Po o sul Tagliamento) mostrano una strada possibile.
4. Le micro-wilderness periurbane
Dove il paesaggio selvaggio è rarefatto, nascono isole di naturalità spontanea: ex cave, zone umide residuali, boschi periurbani, margini agricoli abbandonati. Non sono luoghi “puri”, ma possono diventare laboratori di Land Ethic applicata.
5. Il consumo di suolo: la minaccia invisibile
L’Italia perde ogni giorno nuovi ettari sotto asfalto e cemento. È la forma più silenziosa di distruzione della natura: non fa notizia, ma erode habitat, corridoi ecologici e possibilità future di protezione.
Ambientalismo radicale
Sioli affronta anche la risposta più estrema alla distruzione degli ecosistemi: l’eco-anarchismo di Edward Abbey e il movimento Earth First!. Se Muir difendeva la wilderness attraverso il valore intrinseco, questi gruppi trasformano quell’etica in azione diretta contro l’estrattivismo globale.
Le guerre, l’industrializzazione e gli esperimenti nucleari sono per Sioli i veri motori della devastazione. Abbey, con The Monkey Wrench Gang, propone il sabotaggio come forma di resistenza. Earth First! radicalizza: sette punti di eco-anarchismo che considerano la Terra un soggetto dotato di diritti inviolabili.
È la reazione disperata a un sistema che tratta la natura come un deposito infinito.
L’impegno “senza riserve”
Dal trascendentalismo all’azione
Il percorso tracciato da Sioli è un invito all’impegno. Dalla contemplazione di Thoreau al militante protezionismo di Muir, fino all’etica ecologica di Leopold, l’evoluzione dell’ambientalismo mostra che la filosofia non basta più: deve tradursi in prassi politica.
Se la Land Ethic non diventa azione, se l’interdipendenza resta teoria, l’etica si svuota. Come ricorda Sioli, citando Abbey: una filosofia che non agisce è “la rovina dell’anima”.
Perché leggere Sioli oggi
In difesa della natura selvaggia è un saggio essenziale per comprendere la crisi ecologica contemporanea. Offre gli strumenti per leggere fenomeni attuali — dagli orsi alle alluvioni — attraverso un’etica che supera l’antropocentrismo.
Sioli costruisce un ponte tra Yosemite e le nostre città: mostra che la wilderness non è un altrove, ma una condizione del nostro stesso essere.
Leggerlo significa ritrovare le radici profonde di un impegno senza riserve.
Difendere la natura non è proteggere un luogo lontano: è proteggere quello che siamo.