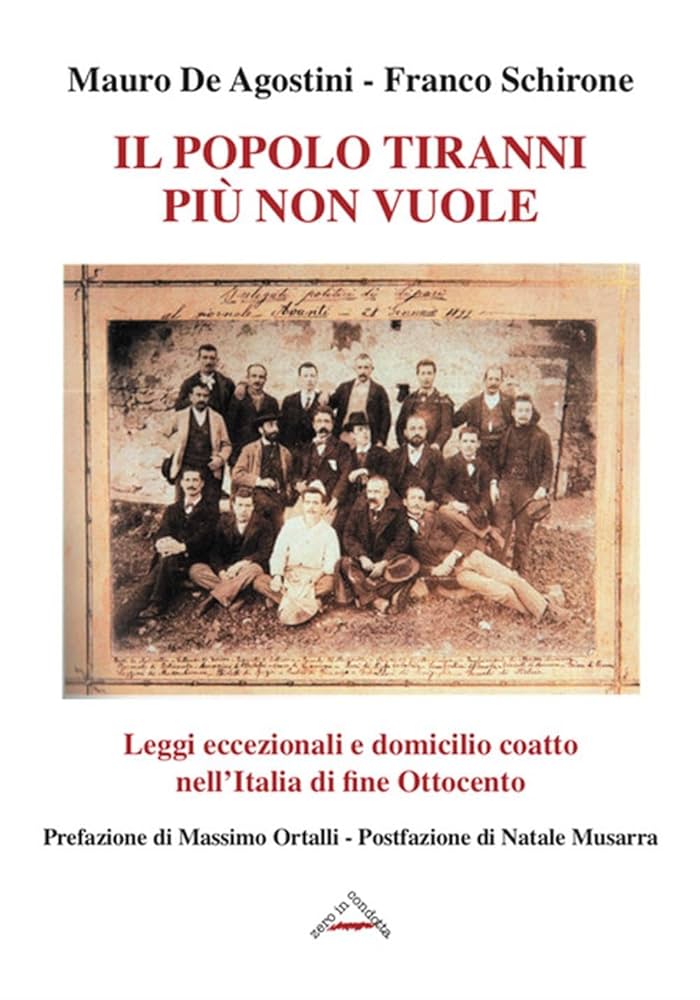“Se Atene piange, Sparta non ride”
1/ Un professore di mio padre diceva che è necessario almeno un secolo perché certi fatti storici vengano valutati con serenità di giudizio e imparzialità. Trovo che avesse ragione. Per valutare con obiettività e con equanimità i fatti spesso bisogna esserne distanti. La vera Storia la devono scrivere i posteri, naturalmente studiando fatti e documenti già raccolti. Naturalmente non voglio in questa sede fare una distinzione tra cronaca e Storia, tra Storia e storiografia, oppure rifarmi al distinguo degli antichi tra cronache e annali. Oggi il susseguirsi degli eventi è incalzante, inarrestabile. Il mondo moderno è caratterizzato da un dinamismo impressionante. Di punto in bianco ecco presentarsi – quando nessuno se lo aspetta – una svolta epocale, per cui al momento è difficile fare disamine o trovare modelli esplicativi adeguati. Si pensi all’11 settembre. Fino ad allora quanti occidentali sapevano le distinzioni tra sunniti e sciiti? Ci eravamo a mala pena “abituati” alle istigazioni al suicidio per uccidere gli infedeli da parte di Khomeini e degli Ayatollah, ma non pensavamo certo che Bin Laden colpisse al cuore l’America. Tutto a un tratto ecco presentarsi una contrapposizione inaspettata tra la solita America gendarme del mondo e gli uomini-kamikaze della Jihad. Ancora oggi questa è attualità, è cronaca. Quanto tempo ci vorrà per metabolizzare questi fatti e farli divenire Storia? Non è un caso quindi che ultimamente la ricerca storica sia in crisi. C’è addirittura chi propone la “microstoria”, ovvero di restringere il campo d’indagine a dei fatti e delle situazioni particolari e più facilmente documentabili.
E’ chiaro che la Storia non può essere mai totalmente obiettiva, ma lo storico può avvicinarsi asintoticamente all’obiettività. In questa sede non voglio nemmeno parlare dei libri sulla resistenza di Pansa. La Storia non la scrivono sempre i vincitori, come ad esempio Churchill. Erodoto e Tucidide sono stati dei grandi storici, eppure erano esuli. E’ altrettanto vero che alcuni storici vincitori rimuovono le testimonianze dei vinti e nascondono gli orrori generati dalla loro parte. Ma la verità viene sempre fuori. Nonostante i negazionisti, che sono i peggiori storici. Niente di nuovo sotto il sole: sono sempre esistiti. Attualmente esistono i negazionisti dell’Olocausto, così come i negazionisti delle foibe; non voglio certo strumentalizzare; è vero che gli italiani fascisti non si erano comportati da “brava gente” in Jugoslavia, avevano commesso eccidi. Bisogna sempre saper contestualizzare ed è una regola che vale per tutti e per tutto. Però anni fa c’erano estremisti che non lasciavano parlare i familiari delle vittime delle foibe alle conferenze e per molti allora le foibe erano solo delle cavità carsiche e niente più. Tempo addietro in Turchia esistevano anche i negazionisti del genocidio armeno da parte dell’impero ottomano, che oggi è stato riconosciuto sia dall’Onu che dal Parlamento europeo. Ancora oggi ben poco sappiamo di tutti i morti che ci sono stati nella repressione del brigantaggio meridionale. Il potere ha sempre tenuto all’oscuro i cittadini per paura che l’effettiva conoscenza dei morti facesse aumentare la voglia di separatismo nel Sud. In tutto questo bailamme mi sembra assurda la domanda che si pone Spengler ne “Il tramonto dell’Occidente”, ovvero se la Storia ha una sua logica. Non credo affatto che la Storia abbia una sua logica, semmai infinite contraddizioni, orrori e atrocità. Popper criticò la miseria dello storicismo, ovvero il determinismo secondo cui la Storia debba per forza avere un senso ed una direzione. Con buona pace di molti la Storia non può essere maestra di vita e grazie a essa non si possono fare previsioni. La Storia è piena di orrori, ma spesso non insegna niente. Si pensi che addirittura i nazisti hanno confezionato i paralumi con la pelle degli ebrei e i rivoluzionari francesi hanno conciato l’epidermide dei reazionari. Abbiamo forse imparato qualcosa da allora? È difficile imparare dagli errori e dagli orrori del passato. Nonostante tutto talvolta la Storia mostra i vichiani corsi e ricorsi. Spesso ci ritroviamo al solito punto di partenza. Secondo Fukuyama il mondo intero sarebbe dovuto arrivare alla “fine della Storia” con la scomparsa del comunismo sovietico. Ebbene questa profezia per il momento non si è avverata. Alcuni sostengono che non siamo alla fine della Storia, ma solo alla fine dell’Antropocene e forse non avremo futuro. Ma ci sono anche scienziati che ritengono che quest’epoca non si possa neanche chiamare Antropocene! Forse esiste solo il progresso scientifico ma non lo sviluppo storico. Se qualcosa può insegnare la Storia, perché conoscere il passato significa conoscere chi eravamo (anche se poco può dirci su chi saremo), di certo molti giovani non sono pronti a raccoglierne l’insegnamento, a causa della loro scarsa memoria storica.
2/ Ma la scuola cosa può fare? Da uomini maturi sappiamo che anche delle nozioni ormai dimenticate possono essere considerate come basi della nostra formazione culturale. Anche libri letti e poi dimenticati hanno plasmato e plasmano i circuiti del nostro hardware intellettuale, delle nostre sovrastrutture intellettuali. Noi siamo anche i libri che abbiamo letto. Anche quelli possono salvarci. Quindi anche se è un poco noioso e a volte non se ne vede l’utilità pratica fa anche bene a uno studente sapere le differenze interpretative de “I promessi sposi” tra Angelo Marchese e Luigi Russo, tra chi riteneva che Manzoni credesse in un deus absconditus e chi in un deus ex machina. Va anche bene imparare ciò che ha scritto la critica sulla redenzione etico-religiosa di Renzo nella notte sull’Adda oppure leggere attentamente l’ultimo capitolo de “I promessi sposi” e imparare che per Manzoni la realtà non è mai idilliaca, che l’idillio non esiste mai. In fondo, anche se preferisco altri autori stranieri, sapere qualcosa di Dante e Manzoni significa sapere qualcosa dell’Italia, degli italiani, di ciò che eravamo: capire come siamo diventati ciò che siamo oggi e capire qualcosa in più di noi. Se non ho fatto mai del male a una mosca (e la tentazione di fare del male agli altri talvolta ce l’avrei veramente, talvolta mi immagino di fare del male a chi non posso soffrire per niente, ma poi desisto), se freno i miei impulsi aggressivi (anche bestiali) forse è anche per i libri letti, per le mie riflessioni su di essi. Ma i libri letti, un poco studiati e dimenticati fanno parte del nostro bagaglio, del nostro retroterra culturale. Ci riparano anche dal male che ci fa il mondo e la vita. Sono quelle pagine dimenticate ormai che forse ci permettono di metabolizzare il male. Forse qualcosa resta delle nozioni apprese a scuola, anche se solo inconsciamente e resta al di sotto della nostra soglia quotidiana di consapevolezza. In fondo i libri basta averli capiti, metabolizzati. Cosa importa se certe nozioni cadono nell’oblio? Certo bisognerebbe ripassare. Ma riprendere certi libri di scuola, ormai polverosi e incartapecoriti, mi immalinconisce, mi intristisce profondamente. Rimarrò con alcune dimenticanze e alcune lacune. Non dimentichiamocelo mai: ognuno ha le sue lacune, ognuno è analfabeta in qualche ramo dello scibile. A volte, certi termini di Dante e Manzoni saranno arcaici, desueti. A tratti la loro concezione del mondo ci sembrerà distante anni luce. In fondo anche se ci siamo dimenticati di quelle pagine, di quelle nozioni in un certo qual modo ci hanno formato come uomini e donne. Però come aggiornare la scuola italiana? Il poeta Maurizio Cucchi qualche anno fa si stupì del fatto che all’esame oggi chiedono le stesse cose che chiedevano a lui decenni fa. La maturità è datata, retrograda. Ma gli insegnanti sono esenti da colpe se i programmi ministeriali delle materie non cambiano. Come rendere attuale la scuola? Come modernizzarla? È proprio alla scuola che si deve chiedere il compito di interpretare la realtà attuale? È la scuola che deve avere la missione di decifrare il mondo attuale? Cosa può dire la scuola sull’uomo contemporaneo e sul mondo attuale? Ma gli insegnanti sono esenti da colpe se i programmi ministeriali delle materie non cambiano. Cosa far studiare ai ragazzi della storia a loro più vicina? Come distinguere tra cronaca e storia? Esiste forse un modo oggettivo? Assolutamente no.
E quale deve essere il rapporto tra scuola e sapere scientifico? Cosa può insegnare oggi la scuola se molti studenti andranno domani a fare un lavoro che oggi ancora non esiste? Jung riguardo al rapporto tra i progressi della scienza e l’umanità aveva scritto: “i voli spaziali sono soltanto una fuga da se stessi, perché è più facile andare su Marte o sulla Luna che penetrare nel proprio io”. In attesa di nuovi stadi evolutivi e di nuove fasi antropologiche l’uomo contemporaneo, la cui psiche non è più una struttura equilibrata e bilanciata, può dimenticare sé stesso nella prassi o nel nuovo misticismo del corpo, ma mai giungere alla sintesi degli opposti, mai approdare alla totalità, considerando lo iato tra natura e arte, tra natura e cultura, tra natura e civiltà. L’uomo contemporaneo non ha più la vitalità sufficiente per vivere il dionisiaco, né la saggezza per giungere all’apollineo. La società di massa e i media non aiutano. Le sensazioni, le informazioni, le notizie sono eccessive e invece di fagocitarle finiamo noi stessi per essere fagocitati da queste. Anche le quisquiglie più irrilevanti, se si tratta di fatti che riguardano i vip, diventano cronaca. Poi interi massacri di popoli lontani vengono taciuti. D’altronde sono i paradossi della modernità. Decenni fa un radiodramma di Orson Welles fu scambiato per un notiziario e creò il panico perché molti americani cedettero che l’America fosse stata invasa dagli extraterrestri. Oggi nessuna notizia crea più scompiglio. In un attimo la novità si perde nel dimenticatoio. Sorel aveva profetizzato che la modernità sarebbe stata caratterizzata sostanzialmente dalla velocità e dalla violenza. Era stato lungimirante. Oggi infatti le notizie vengono presentate e scompaiono rapidamente e nella maggioranza dei casi trattano di cronaca nera. Tutto finisce per essere sciatto, ovvio, banale, risaputo. Un tempo certi libri vengono messi all’indice. Oggi niente fa più scandalo. I romanzi sono troppo lunghi per essere letti. Anche il minimalista e postmoderno Carver, maestro ineguagliabile della short story, non è conosciuto al grande pubblico. Allo stesso tempo nessun saggista prova più un’indignazione per essere un vero pamphlettista. Il mondo è proteiforme. Nazioni, identità, appartenenze, culture stanno scomparendo. Il tessuto sociale si sta disgregando. Stanno scomparendo le comunità e la comunicazione fatica. L’individuo è atomizzato. La massa è anonima. Il potere è così neutro da apparire impalpabile, invisibile. Su tutto prevale l’immagine, la cupidigia, il culto del denaro e un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprovevole moralmente. La trilogia di Mastronardi (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Questa è la civiltà dell’immagine e le masse sono idolatre, solo pochi solitari rabbiosi trovano la forza per essere iconoclasti. L’uomo contemporaneo non sa come utilizzare la libertà. Una libertà inaudita rispetto ai secoli precedenti, ma in fin dei conti una libertà apparente. Dostoevskij aveva già affrontato questa problematica. Paradossalmente potremmo anche concludere che se l’uomo utilizza la libertà come il protagonista di “Delitto e castigo” allora ben venga un Grande Inquisitore, che lo affranca da ogni tipo di libertà, perché ritiene l’uomo un essere immaturo e irresponsabile. La cultura occidentale si sta dissolvendo. L’America ha voluto colonizzare anche il nostro immaginario, volendo far credere nei loro film che gli americani hanno una villetta a schiera con tanto di barbecue e di canestro, i figli al college (che tra l’altro ha dei costi elevati perché non conoscono il significato dell’espressione “diritto allo studio”) , una moglie che va con le amiche a giocare al bridge e un ragazzo che ti porta il giornale ogni mattina. L’affluent society insomma, dimenticandosi di presentare al mondo i senzatetto senza uno straccio di assistenza sanitaria. Il declino è inarrestabile. Lo scrivo a costo di passare per catastrofista. Però noto che queste tematiche non sono contemplate dalle fraseologie dell’ortodossia culturale, che piuttosto cerca di giustificare l’esistente. E la storia cosa può insegnare, stando così le cose? Viene studiata distrattamente nelle scuole superiori e solo quando scoppia una guerra vengono interpellati gli storici in TV a riassumere in due minuti una questione molto complessa e articolata. D’altronde cosa volete? La storia non fa più audience e Rai Storia stava per scomparire.